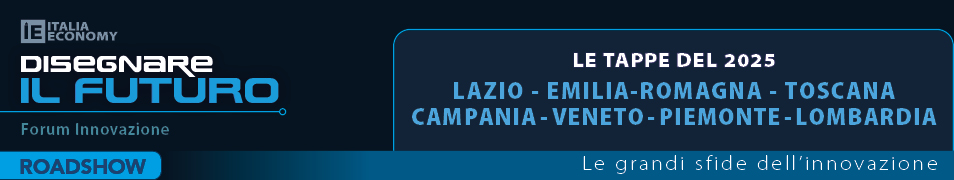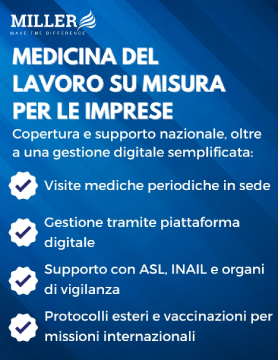Materie prime critiche: da rischio potenziale a fonte di vantaggio competitivo per le imprese
di Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET – Università di Milano-Bicocca e Presidente Brightseed Srl
e di Debora Tortora, Professoressa Associata Economia e gestione delle imprese e Partner Brightseed Srl
L’evidente fragilità degli equilibri geopolitici internazionali, provata dall’intensificarsi delle tensioni strategiche ed economiche a livello globale (tra cui restrizioni alle esportazioni, sanzioni, dazi), e l’acuita rivalità tra grandi potenze (USA e Cina, in primis) rendono sempre più impellente la necessità di riformulare catene del valore globalizzate, quando non direttamente globali, e collegati modelli di business
Eventi ed effetti, che agiscono a diversi livelli, sottendono un minimo comun denominatore, ovvero un più efficace/efficiente controllo delle risorse. Il pensiero va immediatamente alle materie prime critiche, quei materiali di strategica importanza economica per l’Europa e caratterizzati allo stesso tempo da alto rischio di fornitura. Tali risorse sono riconosciute come fondamentali per la transizione green & digital, ma anche per l’impiego in settori strategici, oggi più che mai centrali nelle economie nazionali, come difesa e aerospazio; in effetti, l’appropriazione e uso delle materie prime – in generale – rimane una delle principali fonti di vantaggio competitivo per le imprese.

Tuttavia, una forte concentrazione delle fonti di fornitura anche in Paesi caratterizzati da governance instabili o che applicano politiche restrittive all’esportazione, possibili interruzioni di supply chain sovranazionali, più difficilmente governabili, volatilità dei prezzi, come conseguenza di shock o speculazioni, espongono Stati e organizzazioni a rischi operativi (da cause esterne), il cui fronteggiamento necessita un approccio proattivo senza ulteriori rinvii o esitazioni.
A livello macro, l’Unione Europea ha affrontato la questione solo nel corso dell’ultimo ventennio e con alterni livelli di intensità di attenzione e azione, per arrivare a proporre nel 2024 un quadro normativo, il Critical Raw Materials Act (CRMA), orientato a favorire una maggiore autonomia degli Stati in tema di approvvigionamento e a garantire le capacità necessarie al conseguimento degli obiettivi della green & digital transition. È poi del 2025 l’avvio dell’iter per lo sviluppo di 47 progetti strategici, che ne costituiscono la parte esecutiva. Anche l’Italia, da parte sua, si sta impegnando a definire strategie di gestione delle materie prime critiche in grado di consentire alle imprese nazionali maggiore flessibilità, capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato e alle nuove normative, sostenibilità, sia ambientale che sociale, rafforzamento delle catene del valore, tramite investimenti in infrastrutture, miglioramento della capacità produttiva, ricerca e sviluppo. A livello normativo, poi, il CRMA è stato recepito con il D.L. 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 11532. Il provvedimento, recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”, istituisce un sistema di governance per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali input produttivi, in linea con gli obiettivi europei.

Cosa accade, però, in concreto a livello meso, quando ci si deve confrontare con un tessuto industriale nazionale diversificato e fortemente integrato nelle catene globali del valore? La discussione andrebbe condotta su più piani, per quanto tra loro interrelati.
Innanzitutto, pur concordando solo parzialmente con posizioni entusiastiche e mainstream che attribuiscono all’impiego – si badi solo potenziale – di critical raw material nell’industria italiana la possibile generazione di quasi un terzo del PIL nazionale, di fatto tale utilizzo fruttuoso sarebbe subordinato alla realizzazione nel nostro Paese di tutti quei manufatti che le incorporano, e relative filiere. Ebbene, attualmente l’analisi della domanda effettiva di materie prime critiche e strategiche è espressa soprattutto dai cosiddetti settori tradizionali (bismuto e gomma naturale nel tessile/abbigliamento, fosforo nell’agrifood, bauxite/alluminio e grafite naturale nelle costruzioni). Si rintracciano impieghi anche nei settori strategici, della mobilità elettrica e dell’automotive, ma di modesta entità.
Di conseguenza, pur dovendo seriamente riflettere sulla significatività economica delle materie prime critiche, per cui si rimanda al recente studio (2025) condotto dal CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con ISTAT, dal titolo “Critical Raw Material. Quali sfide per le Materie Prime Critiche, Strategiche e Rilevanti in Italia”, a livello meso si deve spostare l’attenzione sul comportamento che le organizzazioni potrebbero attuare per contenere i citati rischi operativi correlati all’utilizzo di dette materie, che intercettano catene del valore globali. Anche qui l’ottica di osservazione può essere duplice, riguardando le considerazioni che un’impresa effettua nella selezione dei propri fornitori/partner della filiera di riferimento, o riferendosi alle scelte soggettivamente compiute per rassicurare possibili investitori o clienti, siano essi altre organizzazioni o consumatori finali.
In entrambi i casi è necessario ricorrere a strumenti di analisi strategica e competitiva, per valutare come le organizzazioni integrano aspetti legati alla transizione green & digital nei propri processi decisionali, superando un mero approccio compliant o tech rush inspired. Questo perché possibili interruzioni logistiche, subite da un fornitore o da un partner di filiera possono danneggiare brand e vendite dell’impresa cliente, esponendola ad un rischio reputazionale, mentre investitori ESG oriented possono richiedere pratiche sostenibili per erogare finanziamenti, in mancanza delle quali rivolgere altrove la propria attenzione. Inoltre, anche le regole imposte dal CRMA aumentano la necessità di visibilità della supply chain, per garantire maggiore sicurezza delle forniture. Il green digital rating, un framework di analisi proprietario frutto di studi accademici pluriennali ed altrettante esperienze consulenziali, rappresenta un innovativo approccio per questo tipo di analisi, consentendo di gestire una serie di conoscenze utili per mitigare, grazie a valutazioni preliminari e analisi di competitività delle organizzazioni coinvolte nella catena del valore, tali rischi. Il rating, infatti, considerando un sistema organico di molteplici asset – finanziario, tecnologico, reputazionale e ambientale – consente di effettuare un audit esaustivo dell’impresa, arricchito da un benchmark competitivo e da confronti intra-settore e cross-competitor. L’audit considera l’integrazione dei criteri ESG con dati economici, digitali e reputazionali, per valutarne la considerazione nei processi decisionali. Le principali aree di attenzione intercettano quattro dimensioni chiave, ovvero Profit, People, Purpose e Proof (figura 1), declinate in otto dimensioni, quali economic sustainability, data collect & compliance, digital integration & experience, brand awareness, brand reputation, social sustainability, environment sustainability e governance efficacy, misurate attraverso una serie di parametri chiave, per restituire uno score che aiuta a capire dove si colloca l’organizzazione rispetto a competitor e stakeholder (figura 2). La mappatura dei fornitori critici, specie se single source, nella catena del valore o dei partner di filiera o di progetto può facilitare le imprese nella realizzazione di piani di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, così come facilitare la partecipazione a progetti ESG-friendly, aprendo potenzialmente nuove opportunità e nuovi mercati e contenendo il rischio operativo, anzi trasformandolo in potenziale vantaggio competitivo.