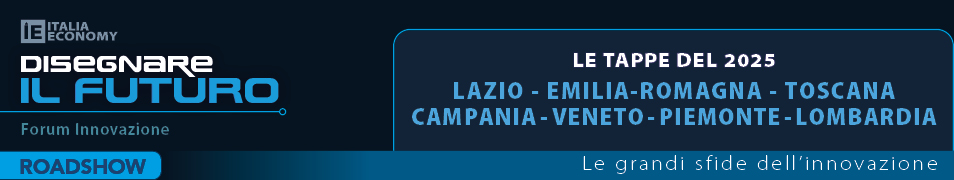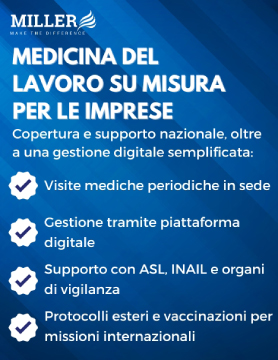Imprese italiane alla prova della transizione energetica: il fotovoltaico, tra innovazione, sostenibilità e gestione del rischio
A firma di Sauro Mostarda, CEO di Lokky
Che la transizione energetica rappresenti oggi una priorità inderogabile è un fatto. Sulla scia delle iniziative promosse dalle principali organizzazioni internazionali – a partire dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – l’Unione Europea ha progressivamente rafforzato le proprie strategie e normative in chiave ambientale, andando a definire obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni e di incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Tra i provvedimenti più significativi si collocano, da un lato, il Green Deal europeo, che delinea un piano complessivo per la riconversione sostenibile dell’economia; dall’altro, la Legge europea sul clima, che sancisce l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, fissando un traguardo intermedio di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
A livello nazionale, la normativa di riferimento che recepisce le direttive europee è rappresentata dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), elaborato congiuntamente dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2019 e aggiornato nel 2023. Questo provvedimento attesta la piena condivisione dello Stato italiano nei confronti della strategia di decarbonizzazione promossa dall’Unione Europea. Inoltre, ribadisce la necessità di un nuovo contratto sociale, un patto verde tra imprese e cittadini, in cui l’ambiente venga percepito come motore economico del Paese.
Nello specifico, il PNIEC definisce gli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni climalteranti, sicurezza energetica e ricerca, in linea con i target comunitari. Tra i punti cardine, il piano prevede che entro il 2030 almeno il 60-65% dell’energia elettrica nazionale provenga da fonti rinnovabili, con un ruolo centrale assegnato al fotovoltaico, la cui capacità installata dovrà superare i 79 GW, quasi triplicando rispetto ai valori attuali [4].
Questi obiettivi, oltre a segnalare una chiara traiettoria verso la decarbonizzazione, impongono al sistema produttivo nazionale una profonda ristrutturazione. Le imprese, in particolare le PMI, sono chiamate a mettere in discussione i propri modelli energetici, non solo in ottica di efficienza, ma, soprattutto, come leva di competitività e gestione del rischio.
È in tale contesto – reso ancora più complesso dall’instabilità geopolitica e dalle tensioni sui mercati energetici internazionali – che il fotovoltaico si presenta come un pilastro strategico della transizione energetica. Difatti, l’energia solare sta diventando una leva strutturale di competitività e sostenibilità per le imprese, oltre che uno strumento di decarbonizzazione per l’intero sistema Paese. Negli ultimi anni le soluzioni B2B si sono diffuse a macchia d’olio, adattandosi alle diverse dimensioni aziendali e alle esigenze energetiche di ciascun settore. Gli impianti cosiddetti rooftop, installati sulle coperture di capannoni industriali o centri logistici, restano la scelta più diffusa, consentendo di autoconsumare gran parte dell’energia prodotta e abbattendo i costi e la dipendenza dalla rete. Da segnalare poi, l’interesse verso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che permettono a più imprese o privati di condividere localmente l’energia prodotta, ottenendo vantaggi economici e fiscali. Infine, sempre più aziende, soprattutto nei settori energivori, si distinguono per l’adozione dei Power Purchase Agreement ( PPA) : contratti a lungo termine che assicurano forniture di energia verde a prezzo stabile, riducendo l’esposizione alle oscillazioni dei mercati. Accanto al comparto industriale, anche il settore residenziale sta conoscendo un’espansione notevole. La progressiva riduzione dei costi di installazione, gli incentivi pubblici e una crescente sensibilità ambientale hanno spinto un numero sempre maggiore di famiglie italiane a investire nel fotovoltaico domestico, spesso integrato con sistemi di accumulo che permettono di massimizzare l’autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica.
Un dinamismo che trova piena conferma anche nei numeri, a partire dai dati elaborati dagli addetti ai lavori. Secondo quanto riporta l’ EU Market Outlook 2024-2028 di SolarPower Europe , nel 2024 nell’Unione Europea sono stati installati 65,5 GW di nuova capacità fotovoltaica, segnando il quarto anno consecutivo di crescita record. La capacità complessiva cumulata ha così raggiunto 338 GW, confermando il fotovoltaico come la principale tecnologia di generazione rinnovabile del continente. Analizzando la capacità installata nei singoli Paesi europei, la Germania guida la classifica con 99,2 GW, seguita da Spagna (46,7 GW), Italia (36,2 GW), Paesi Bassi (26,0 GW) e, infine, Francia (23,5 GW).
All’interno di un quadro europeo in espansione, l’Italia mantiene una posizione di vertice, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione e sicurezza energetica. D’altronde, come attesta il Rapporto Statistico 2024 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il fotovoltaico italiano, sostenuto da misure come il DM FER-1 e il programma Agrisolare, ha registrato un’ulteriore crescita. Al 31 dicembre 2024 risultavano in esercizio 1.875.870 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 37.002 MW, con una crescita del 22% rispetto al 2023.
In sintesi, le statistiche confermano la piena diffusione del settore e la sua crescente rilevanza nella strategia energetica nazionale. In termini di distribuzione geografica, la Lombardia si conferma la regione con la maggiore potenza installata (4,96 GW), seguita da Veneto (3,75 GW), Puglia (3,63 GW) ed Emilia-Romagna (3,57 GW). La Puglia, in particolare, mantiene il primato per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, con 4.639 GWh generati nel 2024, pari al 12,9% del totale nazionale.
A risultare altrettanto significativa è la dimensione economica del fotovoltaico. Secondo quanto emerge dalla Nota Tematica n. 2/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Italia il costo medio d’installazione di un impianto fotovoltaico si attesta intorno a 785 $/kW, un valore inferiore di circa 70 $ rispetto alla media mondiale e largamente più competitivo di Francia e Spagna. Inoltre, negli ultimi dieci anni il costo dell’energia fotovoltaica è diminuito dell’85%, passando da 42 ¢/kWh a 5 ¢/kWh, mentre il costo d’installazione per kW si è ridotto dell’81%.
Tutti questi progressi hanno reso il solare una delle fonti energetiche più efficienti sul piano economico e ambientale, creando le condizioni per un rafforzamento della filiera industriale nazionale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riserva infatti 1 miliardo di euro allo sviluppo di batterie e tecnologie rinnovabili, di cui 400 milioni al fotovoltaico, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza tecnologica estera e stimolare la produzione nazionale. In virtù di costi più contenuti e di un quadro normativo semplificato, l’Italia mostra una dinamica di crescita particolarmente rapida, con 2,5 GW di nuova potenza installata nei primi sei mesi del 2023, riflesso di un settore in piena espansione industriale.
La storia del fotovoltaico in Italia si articola in fasi ben distinte, ciascuna caratterizzata da specifiche dinamiche di mercato e diverse priorità di investimento. Il periodo tra il 2008 e il 2013, coinciso con la stagione del Conto Energia, ha visto una massiccia espansione degli impianti utility scale, con potenze superiori a 900 kWp, prevalentemente realizzati a terra. In quegli anni, secondo i dati GSE, furono installati complessivamente oltre 12,7 GW, con un picco di9,3 GW nel solo 2011. L’interesse degli investitori era catalizzato dalle tariffe incentivanti, che resero il fotovoltaico una nuova forma di investimento anche per gli investitori istituzionali, oltre che da parte di imprenditori locali.
Pressoché esaurito il sistema incentivante nel 2013, il mercato attraversò una fase di stagnazione in cui gli investimenti si contrassero drasticamente per diversi anni. Fu solo a partire dal 2020 che il settore conobbe una nuova accelerazione, questa volta trainata da una logica radicalmente diversa: non più grandi centrali a terra, ma impianti di piccola e media taglia, prevalentemente rooftop, destinati all’autoconsumo aziendale e residenziale. Il boom del segmento distribuito è stato sostenuto dalla diminuzione dei costi tecnologici, dall’instabilità dei prezzi energetici e da nuovi strumenti normativi come le Comunità Energetiche Rinnovabili. Secondo il “National Survey report of photovoltaic power applications in Italy 2022”, solo nel corso del 2022, l’Italia ha assistito a un notevole aumento delle installazioni di impianti fotovoltaici, aggiungendo quasi 2,5 GW di nuova capacità con circa 210.000 nuovi impianti, il valore più alto degli ultimi 9 anni. La capacità totale installata alla fine del 2022 ha raggiunto circa 25 GW, con le installazioni a terra che costituiscono il 34% di questa.
Oggi, si assiste a una fase di maturità del mercato, in cui convivono entrambe le dimensioni: da un lato prosegue la diffusione capillare degli impianti piccoli e medi, dall’altro tornano protagonisti i grandi progetti utility scale, con una sensibilità però rinnovata. I nuovi impianti a terra integrano criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, adottando anche soluzioniagrivoltaiche che consentono la coesistenza tra produzione energetica e attività agricola, o privilegiando il recupero di aree industriali dismesse. Nel primo trimestre 2025, secondo Italia Solare, in Italia sono stati connessi 1,43 GW di nuova potenza fotovoltaica, per un totale cumulato di circa 38,5 GW installati. Gli impianti utility scale, con potenza superiore a 1 MW, hanno rappresentato circa il 48% del totale (pari a 684 MW), confermando il loro ruolo trainante nello sviluppo del settore. Seguono gli impianti commerciali e industriali (20 kW < P ≤ 1 MW) con 407 MW (28%) e quelli residenziali (P ≤ 20 kW) con 341 MW (24%). Questa combinazione tra grandi impianti e generazione distribuita continua a delineare il modello dominante per il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali al 2030.
Tuttavia, la vera sfida non è soltanto tecnologica, ma anche organizzativa e culturale. È necessario costruire un ecosistema capace di integrare imprese, istituzioni, finanza e assicurazioni in un percorso condiviso di sostenibilità. Per le aziende, in particolare, investire nel fotovoltaico non significa più soltanto ridurre i costi energetici, ma anche diversificare il rischio, migliorare i propri indicatori ESG e rafforzare la competitività nel medio-lungo periodo. Ridurre le emissioni e garantire un approvvigionamento energetico rinnovabile consente alle aziende di migliorare il proprio rating di sostenibilità e rafforzare la reputazione presso stakeholder e investitori. In questo modo, possono rispondere con maggiore efficacia alle nuove richieste introdotte dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) .
In questo scenario, la sostenibilità si intreccia sempre più con la gestione del rischio aziendale. Garantire continuità operativa e tutela degli investimenti diventa una parte integrante della strategia d’impresa. È in questo contesto che il settore assicurativo è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Secondo quanto rileva Allianz in una recente analisi sui principali rischi correlati all’energia solare, gli impianti fotovoltaici possono essere esposti a rischi fisici e tecnologici – come eventi meteorologici estremi, incendi o guasti ai moduli – oltre che a interruzioni operative o perdite economiche legate alla mancata produzione. Per questo motivo, le polizze contro i danni materiali diretti, le garanzie di responsabilità civile e le coperture per perdita di profitto da fermo impianto diventano strumenti essenziali per tutelare la continuità operativa delle imprese e garantire la resilienza degli investimenti in energia rinnovabile.
A queste esposizioni tradizionali si aggiungono oggi i rischi informatici, legati alla crescente digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio e controllo. Gli impianti fotovoltaici di nuova generazione, connessi in rete e gestiti da remoto, possono essere vulnerabili ad attacchi hacker o manomissioni dei dati di produzione. Per questo motivo, alle coperture classiche si affiancano sempre più spesso polizze cyber specifiche, pensate per proteggere l’impresa da interruzioni di servizio, perdita di dati e danni economici derivanti da intrusioni informatiche.
Parallelamente, l’evoluzione dei sistemi digitali e dei modelli predittivi consente l’adozione di soluzioni parametriche e di prodotti assicurativi integrati con i dati di performance degli impianti, delineando un nuovo modello di gestione del rischio in chiave energetica e sostenibile.
Il fotovoltaico rappresenta oggi una delle leve più concrete attraverso cui le imprese italiane possono tradurre la transizione ecologica in valore competitivo. La sua adozione, tuttavia, richiede una visione integrata che unisca innovazione tecnologica, pianificazione finanziaria e gestione del rischio. In questa prospettiva, la collaborazione tra aziende, istituzioni e settore assicurativo diventa essenziale per costruire un ecosistema energetico solido, capace di sostenere la crescita industriale e al tempo stesso di garantire stabilità economica.