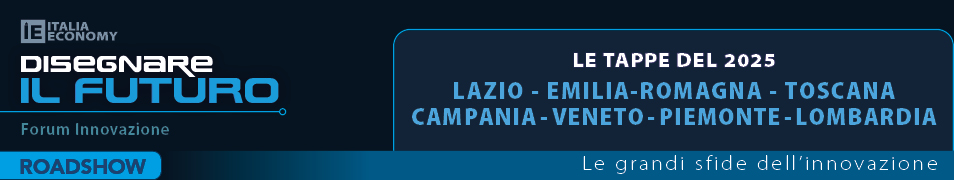La sfida del lavoro dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC: competenze e giovani da attrarre
Il progetto promosso dalla LIUC – Università Cattaneo con Fondazione Cariplo analizza quattro fragilità interconnesse – formazione, inclusione, retribuzione e ageing – e propone strumenti concreti per valorizzare il capitale umano e sostenere la competitività
Quanto incidono l’invecchiamento della forza lavoro, il divario retributivo e la difficoltà di attrarre giovani talenti sulla competitività delle imprese? E come trasformare la carenza di formazione continua in un’opportunità di crescita?
Sono i quesiti al centro del progetto di ricerca LISA (Learning, Inclusion, Salary, Ageing), promosso dalla LIUC – Università Cattaneo con il sostegno della Fondazione Cariplo. L’Osservatorio LISA analizza queste quattro fragilità interconnesse per offrire strumenti concreti alle imprese, utili ad attrarre, valorizzare e trattenere il capitale umano. Ne abbiamo parlato con Eliana Minelli, professore associato di organizzazione aziendale alla LIUC e responsabile del progetto LISA.
Da che esigenza nasce l’osservatorio LISA, quando è nato? E quali caratteristiche di originalità ha nel panorama italiano?

«L’Osservatorio LISA nasce grazie al sostegno della Fondazione Cariplo ed è frutto dell’esperienza maturata con il progetto Interreg Skillmatch-Insubria (2018-2023). Si focalizza sull’area insubrica – che comprende le province di Varese, Como e Lecco, insieme a Novara e Verbano-Cusio-Ossola sul lato piemontese e al Canton Ticino. La specificità del LISA sta nell’affrontare insieme quattro dimensioni che solitamente vengono trattate separatamente. Il progetto considera infatti come apprendimento continuo, inclusione nel mercato del lavoro, divari retributivi e invecchiamento della popolazione siano fattori profondamente interconnessi».
È interessante che parliate di dimensioni interconnesse: può spiegarci un po’ di più questo concetto e le principali osservazioni già emerse in questa prima fase?
«Abbiamo definito le quattro dimensioni di LISA come dimensioni di disu guaglianza, perché non tutti i lavoratori hanno accesso alle stesse risorse. Il territorio dell’Insubria è caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese: realtà tradizionali, flessibili, dinamiche, ma che proprio per le loro dimensioni incontrano dei limiti, soprattutto in termini finanziari. Una grande azienda può investire con continuità in formazione e gestione del personale, può attrarre giovani ad alto potenziale e costruire competenze internamente. Una piccola impresa, invece, fatica: non perché sia meno valida, ma perché mancano le risorse per incentivare, manca una “massa critica” che permetta di sviluppare politiche strutturate di crescita. A questo proposito, rileviamo un panorama frammentato anche in tema di lifelong learning.
Un altro fronte critico è l’inclusione nel mercato del lavoro. Qui tocchiamo un nervo scoperto: l’Italia deve fare i conti con l’invecchiamento demografico e, allo stesso tempo, non dispone di un sistema istituzionale adeguato per favorire l’inserimento di nuova forza lavoro proveniente dall’estero. Le imprese hanno bisogno di personale, ma la popolazione italiana non basta a soddisfare questa domanda. I flussi migratori non hanno compensato la carenza: spesso i nuovi arrivati non hanno le competenze richieste, oppure non vengono loro riconosciute. Noi non affrontiamo la questione da un punto di vista politico, ma di produttività: se il sistema fosse in grado di gestire ingressi qualificati e ben regolati, sarebbe un vantaggio per tutti, per le aziende e per la società.
 Poi c’è il salary gap, che ha due declinazioni principali. Da un lato quello generazionale: le generazioni precedenti hanno beneficiato di sistemi retributivi legati all’anzianità, che oggi non esistono più. I giovani sono esposti a una competizione più intensa e, pur avendo in parte maggiore potere contrattuale vista la loro scarsità, si trovano in condizioni diverse rispetto a chi li ha preceduti. Dall’altro c’è il gender salary gap, un tema complesso e in parte “subdolo”. Non dipende solo da eventuali discriminazioni (già vietate dalla normativa), ma anche da fattori culturali e scelte individuali: le donne tendono a concentrarsi in professioni meno remunerative, sono spesso meno proattive nelle carriere, e la maternità introduce interruzioni che rendono difficile rientrare con le stesse condizioni di partenza. Le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia, ancora forti in Italia, incidono sulle carriere femminili e alimentano il divario.
Poi c’è il salary gap, che ha due declinazioni principali. Da un lato quello generazionale: le generazioni precedenti hanno beneficiato di sistemi retributivi legati all’anzianità, che oggi non esistono più. I giovani sono esposti a una competizione più intensa e, pur avendo in parte maggiore potere contrattuale vista la loro scarsità, si trovano in condizioni diverse rispetto a chi li ha preceduti. Dall’altro c’è il gender salary gap, un tema complesso e in parte “subdolo”. Non dipende solo da eventuali discriminazioni (già vietate dalla normativa), ma anche da fattori culturali e scelte individuali: le donne tendono a concentrarsi in professioni meno remunerative, sono spesso meno proattive nelle carriere, e la maternità introduce interruzioni che rendono difficile rientrare con le stesse condizioni di partenza. Le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia, ancora forti in Italia, incidono sulle carriere femminili e alimentano il divario.
Dalla fine degli anni Sessanta ad oggi la natalità è crollata in modo impressionante, con minimi storici raggiunti nel 2008 e livelli ancora molto bassi. Le scelte di rinunciare o rinviare la maternità aggravano il tema dell’ageing, cioè l’invecchiamento della forza lavoro. E qui entra di nuovo il lifelong learning: con una popolazione lavorativa più anziana e un contesto tecnologico che cambia rapidamente, è essenziale mantenere competenze aggiornate. Non si tratta di combattere un analfabetismo di ritorno, ma di tenere il passo con trasformazioni veloci che già sfidano i giovani, figurarsi chi appartiene a generazioni meno abituate all’apprendimento continuo».
Come si tradurranno i risultati del progetto in strumenti concreti per le imprese: linee guida, benchmark, modelli organizzativi replicabili?
«La nostra idea è tradurre i risultati in strumenti molto pratici per le imprese: linee guida, evidenze, buone prassi ricavate dallo studio dei casi concreti. Un primo obiettivo è mettere in luce le criticità, in particolare negli aspetti legati al learning: l’impostazione della gestione delle risorse umane deve favorire una formazione continua, che non sia episodica ma accompagni le persone fin dall’inizio del loro percorso professionale. Sono buone pratiche già note, ma non sempre realmente adottate dalle aziende. Un altro fronte su cui stiamo lavorando riguarda l’ageing workforce. Parliamo di tecnostress: con la digitalizzazione, le richieste dal punto di vista cognitivo e psicologico aumentano e diventano più gravose per le generazioni meno giovani, che però costituiscono ormai la parte più ampia della popolazione lavorativa. È quindi importante individuare le risorse su cui queste persone possono contare per restare ingaggiate nelle proprie aziende: autonomia, esperienza, capacità di sopportare lo stress, elementi che con l’età spesso si rafforzano, ma che rischiano di non bastare davanti a un’accelerazione tecnologica sempre più spinta».
Avete già prodotto risultati scientifici o applicativi che possano dare un’idea dell’impatto del progetto?
«Abbiamo pubblicato un primo articolo su Sviluppo&Organizzazione,
che adotta una systematic literature network analysis su 413 pubblicazioni indicizzate in Scopus, con un focus specifico sugli older worker. La letteratura conferma l’urgenza di ripensare le pratiche organizzative per affrontare l’invecchiamento della forza lavoro.
Un primo elemento ricorrente è la necessità di flessibilità lavorativa, intesa non come privilegio ma come leva strategica per sostenere benessere e produttività dei lavoratori senior, favorendo la loro permanenza nel mercato del lavoro. Un secondo asse cruciale è l’aggiornamento continuo delle competenze, soprattutto alla luce della crescente automazione e digitalizzazione. Un ulteriore contributo fondamentale riguarda la lotta agli stereotipi e alle discriminazioni legate all’età, che restano barriere culturali forti. Infine, emerge con chiarezza che il concetto stesso di older worker non può più essere definito solo dall’età cronologica, ma va ripensato alla luce di fattori come funzionalità, motivazione, aggiornamento professionale e contesto organizzativo. Le organizzazioni, quindi, sono chiamate a mettere in campo risposte concrete e coerenti, trasformando il fenomeno del workforce ageing in un’opportunità per rafforzare resilienza, continuità e sostenibilità interna».